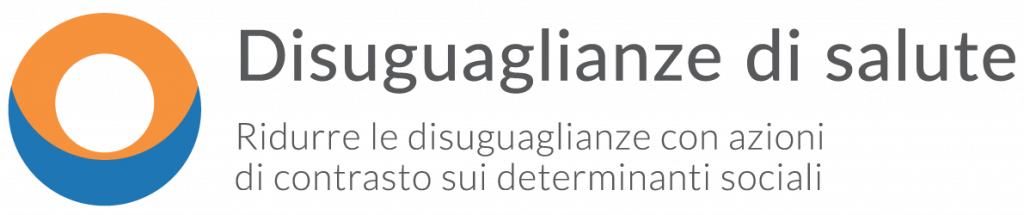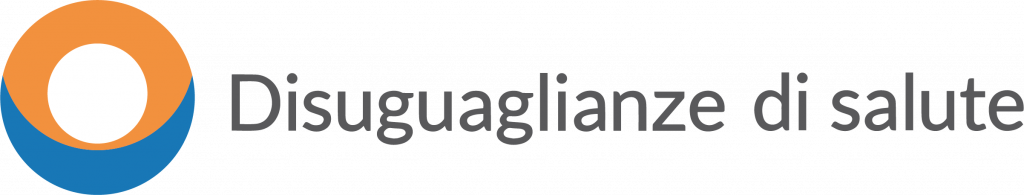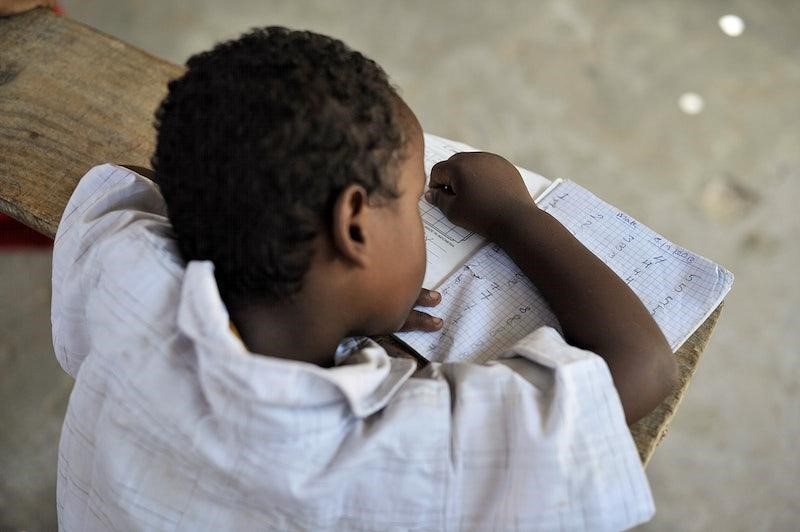Un’istantanea sul presente
I minori di 18 anni rappresentano il 30% della popolazione mondiale, ma, oltre il 40% tra chi è stato obbligato a lasciare il proprio paese di origine per eventi come guerre, persecuzioni, violenze, violazioni dei diritti umani, catastrofi naturali: si parla di migranti forzati. Si tratta di oltre 41 milioni di bambini e giovani.
L’allontanamento forzato dalla propria casa comporta fattori di stress intrinseci prima, durante e dopo la migrazione e richiede la capacità di adattamento a nuovi ambienti. Associati con i determinanti sociali della salute, questi fattori di stress possono aumentare il rischio di problemi di salute mentale. Molti bambini e giovani sfollati con la forza hanno subito considerevoli traumi e affrontano continue difficoltà durante il transito e in fase di reinsediamento nel paese che li accoglie. A circa un bambino e a un giovane rifugiato su cinque può essere diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico, 1 su 6 soffre per disturbi d’ansia e 1 su 8 per depressione.
Tuttavia, in accordo con la letteratura, molti bambini e giovani sfollati a forza sembrano reagire bene e adattarsi alla nuova realtà senza ricadute importanti sul loro benessere psicologico, la cultura d’origine e l’istruzione, soprattutto per chi emigra nei paesi ad alto reddito, presumibilmente contraddistinti per maggiore stabilità politica e disponibilità di risorse. Allo stesso modo, è stato riscontrato che molti dei bambini e dei giovani migranti non soffrono di psicopatologia clinicamente significativa e perciò la definizione di vulnerabili non necessariamente allude a un significato patologico.
Il benessere psicologico è un diritto umano fondamentale e si trova tra gli Obiettivi Globali di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Implica la presenza di funzioni positive ed esperienze che consentono a un individuo di condurre una vita appagante e include sia aspetti interpersonali che intrapersonali, come la valutazione delle proprie competenze o del proprio sviluppo, e l’appartenenza sociale. Poiché è stato riscontrato che i fattori di stress legati alla fase post-migrazione rappresentano un rischio a lungo termine di cattiva salute mentale rispetto ai fattori di stress pre e peri-migrazione, è importante garantire nei bambini la capacità di affrontare problemi e potenziali traumi.
La resilienza psicologica significa la capacità di una crescita positiva nonostante le esperienze avverse ed è strettamente correlata al benessere e alla qualità della vita. Per i minori migranti forzati è un fattore protettivo al pari di altri come ambienti di gioco sicuri, supporto sociale, contatto familiare, dare valore all’istruzione e alle differenze tra culture.
Inoltre è stato riscontrato che i giovani migranti forzati, nei paesi di accoglienza, accedono ai servizi che erogano supporto e assistenza per la salute mentale in misura inferiore rispetto ai loro coetanei nati in loco, per ostacoli diversi, tra cui lo stigma, la sfiducia nei servizi pubblici, un certo grado di analfabetismo culturale e diretto al sistema dell’assistenza sociale e sanitaria. Per questi motivi gli interventi indirizzati alla promozione del benessere e alla prevenzione dei problemi di salute mentale, implementati in un contesto di comunità possono essere di più facile accesso, superare alcune delle barriere sopra esposte e potenzialmente offrire cure più eque ai minori sfollati con la forza.
Esiste numerosa letteratura che sottolinea l’importanza della resilienza, del benessere e della qualità della vita tra i bambini e i giovani migranti obbligati, anche se mancano studi rigorosi relativi agli interventi per promuovere, sviluppare e supportare queste competenze, interventi che intendono aumentare il controllo e la capacità di un individuo di migliorare la propria salute. Altrettanto importanti sono gli interventi di prevenzione, per ridurre il rischio di sviluppare disturbi di salute mentale e trattamento nel caso di patologie diagnosticate.
Ad oggi gli studi relativi a bambini e giovani costretti alla migrazione ruotano intorno all’efficacia dei trattamenti psicosociali (terapia cognitivo-comportamentale, terapia interpersonale), che possono essere efficaci nel ridurre i sintomi, anche se la qualità metodologica è in molti casi debole e poco noti gli effetti a lungo termine. Conclusioni simili in merito all’efficacia sono riportate da due revisioni, Demazure del 2018 e Mitra del 2019, sugli interventi psicologici di prevenzione per minori migranti non accompagnati.
Tuttavia, poiché il numero di bambini e giovani allontanati a forza dalle loro case è in crescita, è necessario approfondire la comprensione dell’efficacia degli interventi preventivi e di promozione del benessere psicosociale oggi disponibili per questa popolazione.
Quali sono gli approcci più efficaci? Spunti da una revisione sistematica
La revisione di Giles e colleghi, pubblicata nel 2025 sulla rivista European child and adolescent psychiatry si pone l’obiettivo di identificare e sintetizzare in modo sistematico gli studi relativi all’efficacia degli interventi di promozione e prevenzione per i bambini e giovani migranti forzati.
Lo studio Giles ha preso in esame gli effetti degli interventi sul benessere, la resilienza e la qualità della vita, e anche sui comportamenti e sintomi internalizzanti ed esternalizzanti (ad esempio, depressione, ansia, disturbo da stress post-traumatico, problemi di condotta, vandalismo, aggressività).
Inoltre, Giles intendeva descrivere i moderatori e i predittori (ad esempio, tipo di prevenzione, paese di trattamento, componenti del trattamento, adattamento culturale) relativi alla riduzione del rischio o della sintomatologia e al miglioramento dei risultati.
La popolazione oggetto dello studio Giles era composta da sfollati interni, rifugiati e richiedenti asilo di età ≤ 18 anni, che hanno partecipato a interventi psicosociali in contesti non clinici, senza la partecipazione dei genitori o dei caregiver. Sono stati esclusi gli interventi che includevano genitori e/o caregiver.
Erano ammissibili tutti i tipi di programmi guidati di promozione e prevenzione della salute mentale erogati esclusivamente a bambini e giovani in contesti non clinici, in qualsiasi paese. Sono universali gli interventi offerti a tutti i migranti minori forzati, indipendentemente dai sintomi o dalle esperienze vissute. Sono stati classificati come selettivi gli interventi indirizzati a chi presenta fattori di rischio specifici (ad esempio, la povertà). Gli interventi destinati a chi è affetto da sintomi di problemi comportamentali, emotivi, internalizzanti o esternalizzanti (inclusi traumi, depressione, ansia), ma senza diagnosi formale di DSM o ICD e implementati in contesti comunitari non clinici (compresi campi profughi/alloggi per richiedenti asilo) sono stati classificati come prevenzione indicata. In letteratura tuttavia gli interventi di prevenzione per sfollati solo raramente vengono classificati secondo i tre livelli.
Sono stati invece esclusi gli interventi che includevano solo partecipanti con livelli clinici di sintomi/diagnosi formale di DSM/ICD o implementati in contesti clinici (ad esempio, reparti psichiatrici aperti).
Il benessere psicologico, la qualità della vita, la resilienza (esiti primari) o i comportamenti internalizzanti (ansia, depressione, ritiro sociale …) ed esternalizzanti (aggressività, bullismo, vandalismo, …) (esiti secondari), devono essere misurati esplicitamente con scale psicometriche convalidate in qualsiasi contesto.
Benessere, qualità della vita e resilienza
Dopo un progressivo processo di selezione degli studi sulla base della lettura degli abstract e del testo completo, alla fine sono stati inclusi 15 studi, 4 studi randomizzati controllati, 4 non randomizzati controllati, 7 pre e post non controllati. Nessuno studio ha incluso misure di follow-up.
I partecipanti (in totale sono 5741), hanno età che variano da 6 a 18 anni e quasi la metà sono femmine, il loro status è principalmente di rifugiati (13 studi), con distinzioni tra sfollati interni (2 studi), richiedenti asilo (2 studi) e sfollati esterni con la forza (2 studi). I partecipanti appartengono a 24 differenti etnie / paesi e gli studi sono stati condotti in 11 diverse aree geografiche, inclusi 8 paesi ad alto reddito.
Per quel che concerne gli esiti primari, solo uno studio include misure validate di benessere e un altro studio misure validate sulla qualità della vita. Uno studio che considera la resilienza non utilizza misure validate.
Lo studio Foka del 2021 ha misurato il benessere utilizzando l’indice di benessere dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’intervento preso in esame è di psicologia positiva – Strengths for the Journey – e consisteva in sei sessioni di gruppo al giorno di 2 ore per giovani di età compresa tra 6 e 17 anni. L’intervento di prevenzione selettiva si focalizza sulla costruzione di risorse psicologiche protettive, come la speranza e le emozioni positive piuttosto che sul trauma. È stato sviluppato e implementato in Grecia, nei campi di transito per sfollati forzati, in lingua araba e farsi, da leader qualificati e traduttori volontari. Il manuale dell’ intervento è disponibile gratuitamente.
Il gruppo che ha ricevuto l’intervento ha riportato aumenti significativi e ampi del benessere rispetto al gruppo di controllo. Sono state condotte analisi di sensibilità per controllare il genere e i livelli alla baseline di autostima.
Lo studio Doumit del 2020 ha misurato la qualità della vita utilizzando il PedsQL 4.0. L’intervento proposto, Creating Opportunities for Patient Empowerment program (COPE, [84]), intendeva sviluppare le competenze cognitivo-comportamentali con lo scopo di aumentare la qualità della vita e promuovere una salute mentale positiva. I partecipanti erano 40 giovani rifugiati siriani che vivono con le loro famiglie in Libano. L’intervento di prevenzione selettiva consisteva in sette sessioni settimanali di un’ora, implementate in un centro della comunità locale. Non è stato descritto alcun adattamento culturale, ma l’intervento è stato implementato dal responsabile della ricerca e da terapisti di lingua araba che hanno tradotto direttamente dal manuale in lingua inglese. Dopo l’intervento sono stati osservati miglioramenti significativi nella qualità della vita nella sua totalità. Tuttavia, l’unica sottoscala del PedsQL [83] a mostrare miglioramenti significativi è stata la scala del funzionamento fisico.
Depressione , disturbo post traumatico da stress, ansia
Gli esiti secondari più comuni negli sfollati minorenni erano i sintomi di depressione, riportata in 11 studi di cui 3 RCT e il disturbo post-traumatico da stress, riportato in 8 studi , di cui 2 RCT. L’ansia invece è stata riportata in cinque studi non randomizzati.
L’unico risultato possibile per condurre una meta-analisi tra gruppo di intervento e gruppo di controllo era la depressione misurata in 3 studi RCT, tutti con rischio moderato di bias. Due studi erano al livello di prevenzione indicata, mentre uno studio era di prevenzione universale/selezionata. I risultati indicano un trend positivo nel gruppo di intervento, anche se non sono statisticamente significativi.
Sempre riguardo alla depressione un’analisi condotta all’interno del solo gruppo di intervento, prima e dopo l’intervento, indica miglioramenti nei sintomi depressivi.
Le caratteristiche degli interventi di promozione e prevenzione della salute per minori sfollati
Riguardo ai 18 interventi esaminati dai 15 studi della revisione Giles, solo lo studio Foka di psicologia positiva si concretizza in promozione della salute mentale, anche se contiene elementi di prevenzione. Nessun intervento ha esplicitato il livello di prevenzione, ma 11 interventi sono stati classificati di prevenzione indicata e 7 di prevenzione universale e/o selezionata . Tutti gli interventi sono stati implementati in gruppo (1-30 partecipanti). La durata dell’intervento variava da 1,5 a 40 ore, distribuite in un periodo temporale che variava da 3 giorni a 16 settimane (6-48 sessioni).
Per quel che concerne i fondamenti teorici la più comune era la terapia cognitivo comportamentale, in 8 interventi, di cui 5 focalizzati sul trauma. Altri fondamenti teorici descritti erano la teoria dell’apprendimento socio-emotivo, il debriefing psicologico, la terapia interpersonale e i programmi di arteterapia con esplicito contenuto psicosociale
Il contenuto degli interventi erano la psicoeducazione, lo sviluppo di competenze e abilità, l’esposizione, tecnica terapeutica in cui una persona affronta gradualmente le situazioni, gli oggetti, i pensieri o le sensazioni fisiche che teme e che tende a evitare, il rilassamento o mindfulness. L’adattamento culturale è stato descritto in 12 interventi e spaziava dalla fornitura a gruppi divisi per genere o traduzioni dal vivo, a programmi completamente confezionati su misura.
La maggior parte degli interventi sono stati attuati nella lingua madre dei partecipanti (nella loro interezza o attraverso traduttori). Era comune che gli interventi includessero facilitatori bilingui, interpreti e/o mediatori culturali, con interventi attuati in una combinazione di lingua del paese ospitante e/o lingua madre dei partecipanti. Due degli interventi inclusi sono stati attuati esclusivamente in inglese e uno in tedesco. Alcuni studi non hanno esplicitato il linguaggio dell’intervento.
Suggerimenti per la pratica e per la ricerca futura
Nella revisione Giles sono carenti gli studi di alta qualità riguardanti gli effetti degli interventi psicosociali di promozione e prevenzione per i bambini e i giovani sfollati con la forza, nonostante la necessità di nuovi studi. Infatti quasi la metà degli studi è stata valutata con un rischio moderato di bias, nessuno con un basso rischio di bias, e tutte le sintesi quantitative, ad eccezione dei miglioramenti dell’ansia nel gruppo, sono state valutate con una certezza delle prove molto bassa.
Pertanto i due soli studi che valutano il benessere e la qualità della vita hanno riportato miglioramenti post-intervento. Si tratta di interventi di promozione della salute mentale e psicologia positiva dall’efficacia promettente. Inoltre tutti gli studi hanno misurato sintomi di salute mentale e/o comportamenti disfunzionali. L’esito più frequente sono stati i sintomi depressivi, seguiti da disturbi post traumatici da stress, ansia, problemi comportamentali ed emotivi e altri comportamenti dal ritiro sociale e isolamento, all’aggressività, gli atti vandalici, il bullismo … Si tratta di interventi di natura preventiva. L’esiguo numero di risultati relativi al benessere è emblematica di certa tendenza della ricerca, in cui l’assenza di problemi di salute mentale viene considerata già di per sé un risultato di benessere.
La meta-analisi degli effetti tra i gruppi di intervento e controllo riguardo alla depressione ha indicato una piccola tendenza non significativa a favore del gruppo di intervento. Le analisi degli effetti dell’intervento, all’interno del gruppo di intervento, riguardo alla depressione hanno indicato effetti medi significativi e positivi. Tuttavia, nonostante seri problemi di eterogeneità che riduce naturalmente l’affidabilità delle prove, queste analisi indicano che potrebbe essere possibile prevenire o invertire lo sviluppo di sintomi depressivi tra i bambini e i giovani sfollati con la forza.
Gli interventi con una percentuale più elevata di partecipanti giovani (< 12) o di sesso femminile hanno avuto più successo nel ridurre i sintomi depressivi, ciò in contraddizione con i risultati riguardanti l’efficacia della terapia cognitivo-comportamentale di gruppo per la depressione in altre popolazioni di adolescenti, dove non sono stati osservati effetti di età o sesso. La tendenza osservata per l’età è incoraggiante, poiché fino al 50% dei problemi di salute mentale debutta prima dei 14 anni e il 75% entro i 25 anni. Inoltre, i giovani di età più elevata sfollati con la forza tendono a riportare una salute mentale generale peggiore e meno miglioramenti nel tempo. Attuare interventi di prevenzione e promozione fin dalla prima adolescenza potrebbe quindi, almeno potenzialmente, prevenire lo sviluppo di sintomi, soprattutto nelle femmine.
Rispetto al luogo, gli interventi erano ugualmente efficaci nel ridurre la depressione, indipendentemente dal fatto che fossero implementati in accampamenti o in contesti comunitari permanenti. Tuttavia, gli interventi che includevano i partecipanti sfollati interni (tutti in accampamenti temporanei) hanno avuto effetti minori rispetto a quelli che includevano i partecipanti sfollati esterni, forse per le condizioni di vita precarie degli sfollati interni.
Gli interventi più rispettosi da un punto di vista culturale, consapevoli e sensibili verso le differenze, possono migliorare l’accettabilità e fidelizzare la partecipazione. Inoltre i programmi che sono stati adattati alla cultura dei loro partecipanti sono più efficaci di programmi nati in altri contesti e trasferiti senza un adattamento culturale. Rientra nell’adattamento culturale il linguaggio con cui viene implementato l’intervento. L’uso di manuali tradotti nella lingua madre dei partecipanti, l’impiego di interpreti o facilitatori bilingue sono una risorsa preziosa, soprattutto quando i destinatari dell’intervento parlano male la lingua del paese che li ospita, come nel caso dei giovani sfollati con la forza. Le barriere linguistiche e culturali possono essere viste sia dai giovani rifugiati che dagli operatori sanitari come un ostacolo all’alleanza terapeutica, aumentando la sfiducia e rendendo potenzialmente “inutili” gli interventi basati sulla parola. Perciò il linguaggio con cui viene effettuato un intervento, che non sempre gli studi riferiscono in modo sistematico, merita invece un’attenzione maggiore, e questa è un’indicazione per gli studi futuri indirizzati a bambini e giovani sfollati con la forza.
Oltre metà degli studi inclusi nella revisione di Glies e colleghi sono stati condotti in paesi ad alto reddito, nonostante il fatto che i paesi ad alto reddito ospitino solo un quarto delle popolazioni sfollate. Questo fatto evidenzia le disuguaglianze in termini di risorse e assistenza nei confronti degli sfollati forzati.
Punti di forza e limiti dello studio
Lo studio Giles sintetizza le conoscenze relative a una popolazione vulnerabile e difficile da raggiungere e da coinvolgere in ricerche scientifiche convenzionali e questo evidenzia il valore dello studio. La qualità metodologica è stata valutata adottando linee guida unanimemente riconosciute: questo rende lo studio replicabile e i suoi risultati confrontabili.
La definizione restrittiva delle popolazioni di bambini e adolescenti sfollati con la forza ha comportato l’esclusione di studi in cui mancava chiarezza sul carattere forzoso della migrazione dei partecipanti. La mancanza di una precisa definizione di popolazioni sfollate con la forza, comprensibile da un punto di vista etico e politico, viene tuttavia visto come debolezza nella ricerca attuale.
Nessuno degli studi inclusi ha definito il livello di prevenzione degli interventi, che è stato perciò assegnato dai ricercatori in base ad una loro valutazione. Definire con precisione i confini tra prevenzione universale e selettiva per questa particolare popolazione è oggetto di dibattito: ad esempio, se gli interventi offerti ai rifugiati possano essere considerati universali o debbano essere designati come selezionati, in quanto l’esperienza stessa di rifugiato può essere visto come un fattore di rischio. Le classificazioni possono quindi essere considerate arbitrarie. Questo studio serve ancora una volta a illustrare quanto sia complesso sintetizzare le prove specifiche sull’efficacia di interventi di promozione e prevenzione per tali popolazioni.
Valutare la qualità metodologica e il rischio di bias di studi relativi ad interventi di natura psicologica reca in sé dei problemi: se da un lato è importante attenersi ai metodi di valutazione raccomandati, non sempre questi metodi sono adatti per la ricerca psicologica clinica. Tutti gli studi inclusi presentavano un maggiore rischio di bias a causa della mancanza di misurazioni in cieco. Tuttavia, pochissimi studi di intervento psicologico possono raggiungere una vera misurazione in cieco ed essere pertanto considerati a basso rischio di bias, se valutati secondo gli strumenti raccomandati.
Sintesi a cura di Paola Capra, DoRS – Centro di Documentazione per la Promozione della Salute – Regione Piemonte
Riferimenti bibliografici
Giles CJ, Västhagen M, van Leuven L, Edenius A, Ghaderi A, Enebrink P. The efficacy of psychological prevention, and health promotion interventions targeting psychological health, wellbeing or resilience among forced migrant children and youth: a systematic review and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2025 Jan;34(1):123-140.
Demazure G, Gaultier S, Pinsault N. Dealing with difference: a scoping review of psychotherapeutic interventions with unaccompanied refugee minors. Eur Child Adolesc Psychiatry 2018; 27(4):447–466.
Mitra R, Hodes M. Prevention of psychological distress and promotion of resilience amongst unaccompanied refugee minors in resettlement countries. Child Care Health Dev 2019; 45(2):198–215.
Foka S et al. Promoting well-being in refugee children: an exploratory controlled trial of a positive psychology intervention delivered in Greek refugee camps. Dev Psychopathol 2021; 33(1):87–95
Doumit R, Kazandjian C, Militello LK. COPE for adolescent Syrian refugees in Lebanon: a brief cognitive-behavioral skill-building intervention to improve quality of life and promote positive mental health. Clin Nurs Res 29(4):226–234