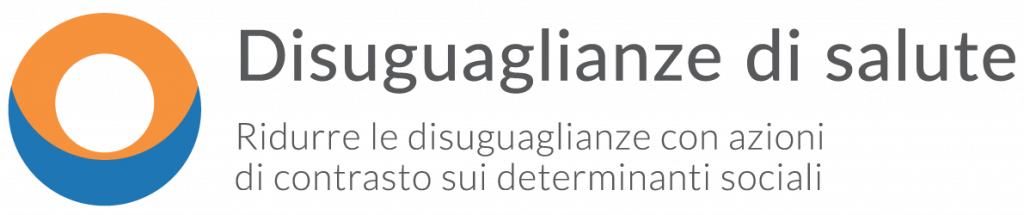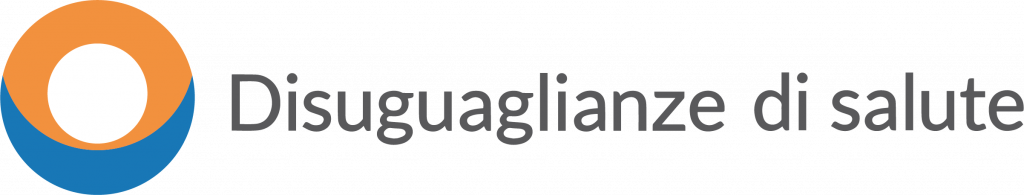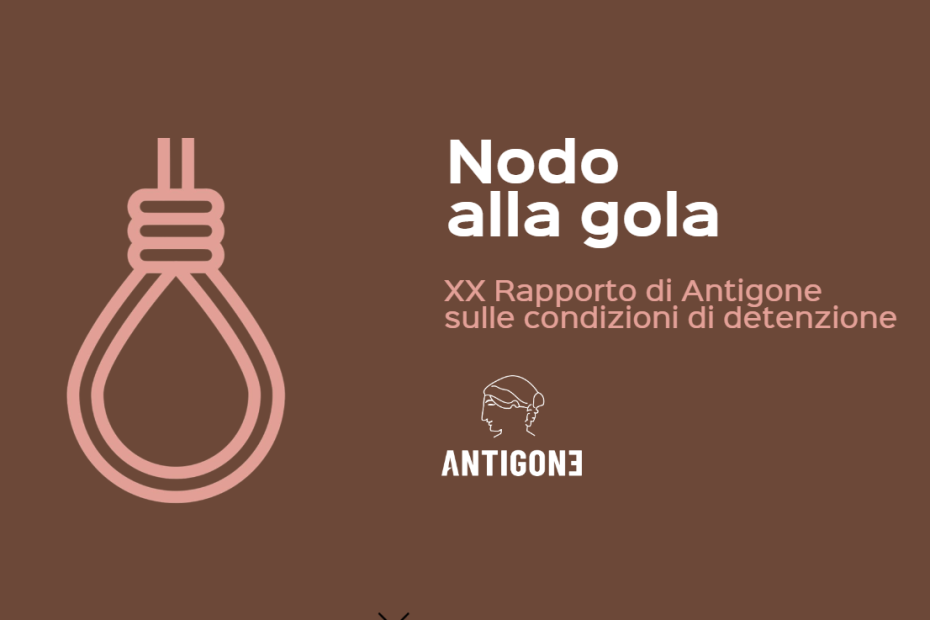“Nodo alla gola” è il titolo, tragico ma di certo esemplificativo, dell’ultimo rapporto redatto dall’Associazione Antigone, che dal 1998, con l’autorizzazione del Ministero della Giustizia, visita periodicamente i quasi duecento istituti penitenziari italiani al fine di documentare le condizioni di vita delle persone detenute.
All’interno del rapporto, redatto a seguito dall’attività di monitoraggio e osservazione sul campo vengono analizzate le condizioni strutturali, il clima detentivo, il rispetto della legge penitenziaria e vengono affrontati alcuni temi salienti della vita detentiva tramite approfondimenti e dossier specifici[1].
Il presente contributo vuole, a partire da tale rapporto, mettere in luce gli aspetti più salienti e determinanti sul tema della tutela della salute, in particolar modo della salute mentale, all’interno delle mura del penitenziario. Sebbene con la legge del 22 giugno 1999 n. 230, entrata in vigore nel 2008, si sia legiferato a favore dell’equivalenza delle cure dentro e fuori le mura, con il trasferimento delle competenze sanitarie dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute, in linea con le normative internazionali che stabiliscono che «i detenuti devono avere accesso ai servizi sanitari disponibili nel paese senza discriminazioni legate alla loro condizione giuridica» (art. 40.3 EPR), nella pratica quotidiana si frappongono numerosi ostacoli nell’esigibilità del diritto alla salute[2].
La tutela della salute in carcere, pur non riconoscendo specifiche patologie ad etiopatogenesi esclusivamente carcerarie, anche in frequente concomitanza ambientale, presenta delle specificità proprie che sono legate al contesto detentivo. Tali specificità dipendono da differenti fattori, innanzitutto dalle difficoltà riscontrate nel bilanciamento fra istanze istituzionali differenti, se non quando confliggenti: garanzia di salute e di sicurezza[3].
Altrettanto determinanti sono: il sistema giudiziario e quello penitenziario, le condizioni delle strutture fisiche di esecuzione penale, nonché il particolare tipo di utenza, che è spesso portatore di bisogni di salute più complessi[4].
Inoltre, la copertura sanitaria nelle carceri non è omogenea in tutto il territorio nazionale: vi sono, infatti, notevoli differenze – non solo fra le Regioni, ma anche fra i singoli istituti – in termini di offerta e accessibilità dei servizi sanitari; dunque, restituirne un quadro d’insieme è molto complesso.
Per introdurre le problematiche legate alle condizioni strutturali è doveroso partire dal dato primario relativo alla capienza: a fine marzo 2024 le persone detenute erano 61.049, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti – capienza ulteriormente ridotta a causa delle numerose aree rese inagibili[5].
Dopo il decremento avvenuto nel 2020 – in conseguenza della pandemia da Covid-19 – negli ultimi anni si è assistito nuovamente ad un innalzamento del tasso di affollamento, che a inizio anno si collocava intorno al 119,3%, con regioni in cui la media nazionale veniva largamente superata, raggiungendo il 150%.
Inoltre, bisogna sottolineare che è cambiata la composizione demografica: all’interno delle mura si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione, con un incremento in corrispondenza della fascia d’età tra i 45 ei 59 anni (che, attualmente, rappresenta il 32,2% del totale della popolazione detenuta) e degli over 60, e un decremento degli under 35.
Tali cambiamenti avranno sul lungo andare, inevitabilmente, un impatto significativo sul sistema sanitario e assistenziale all’interno; senza tralasciare che, in generale, i bisogni di salute e, di conseguenza, i consumi di beni e servizi sanitari della popolazione carceraria sono, tendenzialmente, più elevati rispetto alla popolazione libera sia a causa delle vulnerabilità importate[6] sia a causa degli effetti iatrogeni insiti nell’abitare in carcere.
Secondo alcune stime epidemiologiche, la permanenza in carcere è predittiva non solo di un peggiore stato di salute degli ospiti, ma anche di un più rapido processo di invecchiamento rispetto alla popolazione generale[7]. A fronte di tali cambiamenti è mancata, tuttavia, una risposta adeguata in termini di numerosità del personale medico sanitario e adeguamento degli spazi e degli ambienti. Oltre alla carenza del personale giuridico-pedagogico si registra anche uno squilibrio nel servizio psichiatrico (in cui le ore di servizio erano in media 9,14 ogni 100 detenuti), in quello psicologico (19,8 ore ogni 100 detenuti) e in quello medico: in 41 istituti su 99 non è presente un medico 24 ore su 24. Inoltre, in 64 su 99 non è disponibile la cartella clinica informatizzata.
A questi dati scoraggianti si aggiungono, come accennato in precedenza, le critiche condizioni strutturali degli istituti di pena, che presentano spazi ristretti e ambienti fatiscenti; sebbene si proponga spesso come soluzione al sovraffollamento l’investimento in nuove strutture e padiglioni, all’interno delle previsioni di bilancio del biennio 2024-2026, la voce afferente la realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell’ambito dell’edilizia carceraria è stata notevolmente ridotta (-10,8% rispetto agli scorsi anni).
Salute mentale
Nel trattamento della patologia psichica il carcere dimostra tutta la sua inadeguatezza di spazi, professionalità e risorse, come scrive Michele Miravalle “Il carcere è tossico, nuoce alla salute, soprattutto quella mentale” (Antigone, 2024). Attualmente il 12% delle persone detenute (quasi 6.000 persone) ha una diagnosi psichiatrica grave. Gli spazi interni dedicati al trattamento delle patologie psichiatriche, soprattutto nella fase più acuta, sono chiamate Articolazioni per la Tutela della Salute Mentale (ATSM), i “repartini”, nel gergo carcerario; in Italia sono 32 le ATSM collocate in 17 istituti penitenziari, uno per regione. Ingenuamente ci si potrebbe chiedere perché il tema della salute mentale in carcere sia così sentito e diffuso se solo 300 persone sul totale sono pazienti psichiatrici acuti in carcere.
La ragione è che in realtà le ATSM affrontano solo una piccola parte del problema, e non fotografano affatto il disagio mentale diffuso nelle altre sezioni, né l’evidente tendenza alla psichiatrizzazione degli spazi detentivi. Il principale strumento di governo della salute mentale, dunque, diventa il ricorso massiccio agli psicofarmaci, utilizzati con finalità non solo terapeutico-sanitarie, ma di “sedazione collettiva” e “pacificazione” delle sezioni; i numeri sono impressionanti: il 20% persone detenute (oltre 15 mila) fanno regolarmente uso di stabilizzanti dell’umore, antipsicotici e antidepressivi; il 40% (30 mila persone) fa uso di sedativi o ipnotici. Nel 2023, Altraeconomia in un’indagine svolta con Antigone ha evidenziato come la spesa per psicofarmaci nelle carceri italiane avesse superato i due milioni di euro, con un utilizzo cinque volte superiore rispetto alla popolazione generale e ne sono esempi lampanti gli istituti di Milano (con un aumento del 180% dal 2018 al 2022), e Torino (+ 74%). Gli antipsicotici, utilizzati per gravi patologie come schizofrenia e disturbo bipolare, infine, costituiscono il 60% della spesa totale in psicofarmaci.
Atti autolesionistici e suicidi
I numeri del disagio mentale hanno raggiunto livelli allarmanti: si registrano in media, ogni 100 persone detenute 18,1 gesti autolesivi, 2,4 tentati suicidi e 3,5 aggressioni al personale. Al 17 settembre 2024, i casi accertati di suicidio in carcere sono almeno 72[8], ovvero 19 in più rispetto ai 53 che si registravano nello stesso periodo nell’anno precedente e 3 in più di quanti se ne siano registrati in tutto il 2023. Ciò appare ancor più preoccupante se confrontiamo questi dati con quanto avviante all’esterno, ove il tasso di suicidi è 18 volte in meno rispetto a quanto succede in carcere. L’osservazione di Antigone ha evidenziato come la scelta suicidaria sia legata ad alcuni fattori di disagio e/o fragilità: nel Dossier sui suicidi, allegato al Rapporto, viene osservato come il 6% dei suicidi avvenuti in istituto nel 2023 e nei primi mesi del 2024 sia stato messo in atto da donne (che compongono la popolazione detentiva solo per il 4,3%); il 42% da persone straniere (presenti in carcere per il 31,3%); e il 30% da persone portatrici di disagio psichico e/o affette da tossicodipendenza. Un’ulteriore riflessione proposta da Antigone riguarda, poi, il momento dell’anno in cui si concentrano i gesti suicidari: quello estivo è senza dubbio il periodo più difficile per la popolazione carceraria che si trova a dover affrontare la chiusura delle attività che danno un senso e un ritmo alla quotidianità, insieme all’ulteriore diminuzione del personale penitenziario a causa delle ferie, il tutto in un clima rovente.
Accedi al Report “Nodo alla gola. XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione “
[1] Nel corso del 2023 l’Osservatorio di Antigone ha visitato 99 istituti penitenziari. Tutte le schede delle visite fatte sono pubblicate sul sito https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/ .
[2] Cfr. European Prison Rules (EPR); HAYTON P., GATHE RE R A . , FRA S E R A. (20I0 ), Patient or Prisoner: Does /t Matter which Government Ministry fs Responsible for the Health of Prisoners?,WHO, Copenhagen.
[3] Cfr. D. Ronco, Cura sotto controllo. Il diritto della salute in carcere, Carocci, 2018.
[4] Cfr. sulla salute delle persone private recluse https://www.who.int/europe/health-topics/prisons-and-health ; cfr. sulla salute delle donne recluse: https://iris.who.int/handle/10665/349844
[5] L’inagibilità delle aree è una situazione diffusa in tutte le carceri italiane ed è dovuta alla vetustà degli edifici, malfunzionamento e deterioramento.
[6] Cfr. Massaro P., Un’analisi delle disuguaglianze di salute dei detenuti attraverso il quadrilatero di Ardigò, in Salute e società, Franco Angeli, 2018.
[7] Cfr. Mancinelli R., Chiarotti M., Libianchi S., Salute nella polis carceraria: evoluzione della medicina penitenziaria e nuovi modelli operativi, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2019.
[8] Sono esclusi i casi in cui non è ancora accertata la causa del decesso
A cura di Francesca Bonetto (1), Eleonora Cantaro (1), Chiara Morganti (2)

(1) volontarie Associazione Antigone
(2) Università degli Studi di Torino
Contatti: francesca.bonetto93@gmail.com; eleonora.cantaro.to10@gmail.com; chiara.morganti@unito.it